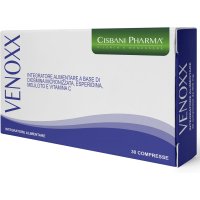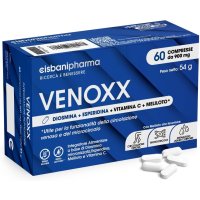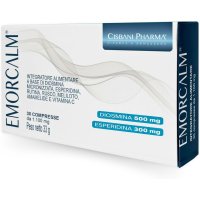Blog

Cosa sapere Sulle Emorroidi: Sintomi, Cause e Soluzioni Efficaci
Le persone sopra i 50 anni hanno una maggiore probabilità di contrarre le emorroidi. Cause e sintomi sono sempre le stesse indipendentemente dall'età. Questa condizione può manifestarsi in tre diverse forme: esterne, interne e prolassate, ognuna con caratteristiche specifiche.
Prima di iniziare a parlare dei sintomi è importante osservare le cause che portano a questo disturbo: dalla gravidanza all'obesità, da una dieta povera di fibre alla sedentarietà prolungata. I sintomi variano notevolmente tra emorroidi interne ed esterne. Le prime possono causare sanguinamenti indolori durante l'evacuazione, le seconde spesso provocano prurito, dolore e gonfiore.
In questa guida completa, esploreremo insieme tutti gli aspetti fondamentali di questa condizione: dai sintomi iniziali alle cause scatenanti, dalle opzioni di trattamento alle misure preventive più efficaci. Il nostro obiettivo è fornire informazioni chiare e pratiche per aiutarti a comprendere, gestire al meglio ed ove possibile, prevenire questa problematica così diffusa.
Cosa sono le emorroidi: definizione e classificazione
Le emorroidi non sono una patologia. Innanzitutto, si tratta di strutture vascolari normalmente presenti nel nostro corpo, precisamente dei cuscinetti venosi situati nel canale anale e nel retto distale. Questi cuscinetti svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento della continenza fecale e contribuiscono alla discriminazione del contenuto rettale.
In generale, parliamo di malattia emorroidaria quando queste strutture si gonfiano o si infiammano, causando vari disturbi. Questa condizione si manifesta attraverso la congestione delle vene emorroidali e il prolasso della mucosa ano-rettale sovrastante, tecnicamente denominato prolasso mucoemorroidario.
La classificazione più utilizzata per valutare la gravità della malattia emorroidaria si basa sull'entità del prolasso e prevede quattro gradi crescenti:
- I grado: le emorroidi sanguinano ma non prolassano fuori dall'ano
- II grado: prolassano durante lo sforzo defecatorio ma rientrano spontaneamente
- III grado: il prolasso emorroidario deve essere riposizionato manualmente nell'ano
- IV grado: il prolasso è permanentemente esterno e non può essere riposizionato manualmente
Questa classificazione, nota come criteri di Goligher, risulta fondamentale sia per la diagnosi che per la scelta del trattamento più adatto al singolo caso.
Differenza tra emorroidi interne ed esterne
La distinzione principale tra emorroidi interne ed esterne riguarda la loro posizione rispetto alla linea dentata (o pettinata) dell'ano, che rappresenta un importante punto di riferimento anatomico.
Le emorroidi interne si sviluppano al di sopra della linea dentata, all'interno del retto, e sono ricoperte dalla mucosa rettale. Pertanto, non sono visibili esternamente e risultano generalmente indolori poiché questa zona è priva di recettori del dolore. Si trovano nel plesso emorroidario superiore e sono drenate dalle vene rettali superiori e medie.
Dal punto di vista clinico, è importante notare che le emorroidi interne si manifestano tipicamente con sanguinamenti dopo la defecazione, dove il sangue viene notato sulla carta igienica o nel water. Tuttavia, raramente causano dolore intenso come le emorroidi esterne, specialmente quando queste ultime vanno incontro a trombosi.
Al contrario, le emorroidi esterne si formano al di sotto della linea dentata, sono ricoperte da epitelio squamoso e si sviluppano al di fuori dell'orifizio anale. Sono facilmente visibili e, a differenza delle interne, possono risultare particolarmente dolorose poiché la zona è ricca di terminazioni nervose. Il plesso emorroidario esterno è tributario della vena rettale inferiore, ramo della vena pudenda interna.
Le emorroidi esterne si presentano invece come noduli di varia grandezza, di colorito rosso violaceo, molli, disposti sul contorno dell'ano. Quando si verifica la trombosi emorroidaria, ossia la formazione di un coagulo di sangue all'interno dell'emorroide, il nodulo diventa intensamente dolente, aumenta di volume e consistenza.
In conclusione, comprendere la classificazione e le differenze tra emorroidi interne ed esterne rappresenta il primo passo fondamentale per riconoscere i sintomi e individuare il trattamento più appropriato per questa condizione così diffusa ma spesso fraintesa.
Sintomi delle emorroidi: come riconoscerle
Riconoscere i sintomi delle emorroidi rappresenta il primo passo fondamentale per affrontare efficacemente questo disturbo così comune. Molte persone, tuttavia, convivono con questa condizione senza saperlo, poiché non sempre si manifestano fastidi evidenti.
Quando le emorroidi si infiammano, possono presentarsi con una serie di sintomi caratteristici che variano notevolmente in base alla loro localizzazione. Pertanto, è essenziale saper distinguere i segnali specifici delle emorroidi interne ed esterne.
Sintomi emorroidi interne: quali sono?
Le emorroidi interne, essendo localizzate all'interno del retto, non sono visibili a occhio nudo e spesso risultano indolori durante le fasi iniziali. Questo avviene perché la mucosa che le riveste è priva di recettori del dolore.
Il sanguinamento indolore durante l'evacuazione rappresenta il sintomo principale delle emorroidi interne. Si tratta generalmente di sangue rosso vivo che può essere notato sulla carta igienica, nelle feci o nel water. In molti casi, questo sanguinamento è l'unico segnale della loro presenza, specialmente nelle fasi iniziali.
Inoltre, le emorroidi interne prolassate possono causare secrezione di muco con conseguente sensazione di umidità, prurito e persino la sensazione che il retto non sia completamente svuotato dopo l'evacuazione.
Nonostante le emorroidi interne siano generalmente indolori, quando si verifica un prolasso avanzato o una trombosi, il dolore può diventare significativo, accompagnato da tutti gli altri sintomi amplificati.
Sintomi emorroidi esterne: quali sono?
Le emorroidi esterne risultano facilmente visibili e palpabili. Si presentano come noduli di consistenza turgida, simili a una "pallina" al margine dell'orifizio anale.
Il sintomo principale è il dolore, che può essere particolarmente intenso quando le emorroidi sono sottoposte a tensione. Questa sensazione dolorosa si accompagna spesso alla percezione di un corpo estraneo a livello dell'ano.
Sintomi frequenti delle emorroidi esterne sono:
- Prurito anale (intenso e persistente)
- Bruciore
- Gonfiore nella regione anale
- Irritazione della pelle circostante
Nelle fasi più avanzate, le emorroidi esterne possono causare perdite di muco con fastidiosa sensazione di bagnato e stimolo a evacuazioni ripetute.
Una complicazione frequente e particolarmente dolorosa è la trombosi emorroidaria, che si verifica quando si forma un coagulo di sangue all'interno dell'emorroide. In questo caso, il nodulo diventa fortemente dolente, aumenta di volume e assume una colorazione bluastra o violacea nelle persone con pelle chiara, mentre appare marrone o nera nelle persone con pelle scura.
È importante sottolineare che molti dei sintomi descritti possono essere comuni ad altre condizioni ano-rettali. Di conseguenza, in caso di sanguinamento ano-rettale persistente o altri sintomi preoccupanti, è fondamentale consultare tempestivamente uno specialista, che potrà escludere patologie più gravi come tumori del colon-retto.
Perché vengono le emorroidi: cause principali
La malattia emorroidaria non si sviluppa casualmente, ma è il risultato di diversi fattori che agiscono singolarmente o in combinazione. Comprendere le cause di questa condizione è fondamentale non solo per trattarla efficacemente, ma soprattutto per prevenirla.
Il nostro modo di vivere influisce direttamente sulla salute del tratto ano-rettale. Tra i fattori più rilevanti troviamo:
- Stipsi cronica, che costringe a sforzi eccessivi durante l'evacuazione
- dieta povera di fibre
- Sedentarietà
- Abitudini quotidiane sbagliate, come trascorrere troppo tempo in bagno durante l'evacuazione o mangiare cioccolato, spezie, alcolici e insaccati
- Sovrappeso e l'obesità, che aumentano la pressione intra-addominale
- Gravidanza
Gli studi scientifici hanno evidenziato una significativa componente ereditaria nella malattia emorroidaria. Recenti ricerche hanno identificato geni in 102 regioni del genoma umano che aumentano il rischio di sviluppare questa condizione.
È importante distinguere tra ereditarietà e familiarità. L'ereditarietà riguarda le caratteristiche trasmesse attraverso il patrimonio genetico, mentre la familiarità si riferisce a fattori comuni condivisi da individui dello stesso nucleo familiare, come abitudini alimentari e stile di vita.
Le analisi dimostrano che chi ha familiari con emorroidi presenta un rischio doppio o triplo di soffrirne a propria volta. In particolare, una grave malattia emorroidaria può essere parzialmente attribuita a una disfunzione geneticamente causata del muscolo intestinale e del tessuto connettivo.
Un esempio specifico è la sindrome di Ehlers-Danlos, una malattia ereditaria caratterizzata dalla mancanza di collagene che può compromettere i tessuti del pavimento pelvico. Anche l'assenza di valvole all'interno delle vene emorroidarie rappresenta un difetto che può portare a un'eccessiva pressione vascolare e gonfiore.
Diagnosi e valutazione medica: la visita proctologica
La diagnosi corretta delle emorroidi richiede un approccio medico strutturato e non dovrebbe mai basarsi sull'autodiagnosi. Innanzitutto, è fondamentale sottolineare che il sanguinamento ano-rettale dovrebbe essere attribuito alle emorroidi solo dopo aver escluso condizioni più gravi.
La visita proctologica rappresenta il gold standard per la diagnosi delle emorroidi. Eseguita da un medico specializzato (proctologo o colonproctologo), questa valutazione inizia con un colloquio approfondito sulla storia clinica del paziente e sui sintomi manifestati.
Durante la visita, il proctologo esegue diverse procedure diagnostiche:
- L'ispezione della regione anale
- L'esplorazione digitale rettale
- L'anoscopia
Inoltre, la visita proctologica permette di classificare le emorroidi interne in quattro gradi differenti in base alla loro gravità, guidando così la scelta del trattamento più appropriato.
L'anoscopia è l'esame fondamentale per valutare le emorroidi non dolorose o sanguinanti. Questo esame viene effettuato mediante l'introduzione nel canale anale di uno strumento chiamato anoscopio, un tubicino lungo 5-6 cm che permette la visione diretta del canale ano-rettale.
In alcuni casi, possono essere necessari esami più approfonditi come:
- La rettosigmoidoscopia, che permette la visualizzazione del retto e del sigma, particolarmente importante per escludere altre patologie.
- La colonscopia, indicata specialmente per i pazienti con più di 50 anni o in caso di predisposizione familiare per tumori del colon-retto. Questo esame è fondamentale per escludere che i disturbi derivino da altre patologie, in particolare da un tumore del colon-retto.
Quando consultare uno proctologo?
È essenziale consultare immediatamente un proctologo quando si è in presenza di:
- Sanguinamento rettale, indipendentemente dall'entità
- Dolore persistente o intenso nella regione anale
- Presenza di noduli, tumefazioni o secrezioni
Cambiamenti nelle abitudini intestinali
Trattamenti efficaci: dalle terapie conservative alla chirurgia
Il trattamento delle emorroidi prevede un approccio graduale che progredisce dalle misure conservative fino alla chirurgia nei casi più gravi. La scelta della terapia dipende principalmente dal grado della patologia emorroidaria e dalla gravità dei sintomi.
I cambiamenti nello stile di vita rappresentano il primo passo per alleviare i sintomi delle emorroidi con:
- Una dieta ricca di fibre (frutta, verdura, legumi)
- Assunzione regolare di acqua
- Attività fisica regolare, anche leggera ma costante
- Bidet tiepidi con detergenti liquidi dopo ogni evacuazione
Numerosi prodotti topici come pomate, supposte e gel rettali offrono sollievo temporaneo dai sintomi. Questi contengono spesso:
- Anestetici locali (benzocaina, lidocaina, tetracaina) per ridurre il dolore
- Antinfiammatori steroidei (idrocortisone, desametasone) per diminuire l'infiammazione
- Estratti vegetali (ruscogenine) con azione antinfiammatoria e vasocostrittrice
Quando i trattamenti leggeri non sono abbastanza sono necessarie delle procedere più complesse:
- Procedure ambulatoriali mini-invasive
- Interventi chirurgici
Per le emorroidi di II e III grado che non rispondono alle terapie conservative sono disponibili varie opzioni mini-invasive:
- La legatura elastica è la procedura ambulatoriale più diffusa
- Scleroterapia (iniezione di sostanze sclerosanti)
- Fotocoagulazione a infrarossi e le terapie laser che interrompono l'afflusso di sangue ai cuscinetti emorroidari.
La chirurgia diventa necessaria quando le terapie conservative falliscono, in caso di prolasso difficilmente riducibile o sanguinamento persistente le opzioni sono:
- L'emorroidectomia secondo Milligan-Morgan (procedura chirurgica di colonproctologia) è l'intervento più diffuso
- Metodica THD Doppler (dearterializzazione emorroidaria transanale)
Gli interventi moderni garantiscono un recupero più rapido rispetto al passato, con un ritorno alle normali attività in 7-15 giorni nei casi mini-invasivi, contro i 30 giorni necessari per l'emorroidectomia tradizionale.
Conclusione
Abbiamo esaminato approfonditamente sintomi, cause e trattamenti disponibili, evidenziando come questa condizione possa manifestarsi diversamente nelle emorroidi interne ed esterne. Particolare attenzione merita la prevenzione: una dieta equilibrata ricca di fibre, adeguata idratazione e regolare attività fisica rappresentano elementi fondamentali per ridurre il rischio di sviluppare questa patologia.
Ricordiamo che qualsiasi sanguinamento rettale richiede una valutazione medica specialistica. Le moderne tecniche diagnostiche e terapeutiche offrono soluzioni efficaci, dalle terapie conservative agli interventi mini-invasivi, fino alla chirurgia tradizionale nei casi più complessi.
La gestione ottimale delle emorroidi dipende dalla tempestività dell'intervento medico e dall'aderenza alle indicazioni terapeutiche prescritte. Quindi, davanti ai primi sintomi, consultare un proctologo rappresenta la scelta più saggia per garantire un trattamento efficace e prevenire possibili complicazioni.
La malattia emorroidaria, sebbene diffusa e talvolta imbarazzante, risulta gestibile attraverso interventi mirati e tempestivi. Certamente, la chiave per affrontare questo disturbo risiede nella diagnosi precoce e nell'adozione di uno stile di vita appropriato.
Sintomi emorroidi: le domande più comuni
Q1. Come prevenire le emorroidi? Per prevenire le emorroidi è importante seguire una dieta ricca di fibre, bere molta acqua, fare regolare attività fisica e evitare di sforzarsi eccessivamente durante l'evacuazione. Mantenere un peso corporeo sano e non trascorrere troppo tempo seduti può anche aiutare a ridurre il rischio.
Q2. Quali sono i sintomi principali delle emorroidi? I sintomi più comuni includono sanguinamento durante l'evacuazione, prurito e irritazione nella zona anale, dolore o fastidio, gonfiore intorno all'ano e la sensazione di un nodulo o protuberanza vicino all'apertura anale. La gravità dei sintomi può variare a seconda che si tratti di emorroidi interne o esterne.
Q3. Quando è necessario consultare un proctologo per le emorroidi? È importante consultare un medico in caso di sanguinamento rettale persistente, dolore intenso nella regione anale, presenza di noduli o tumefazioni, o cambiamenti nelle abitudini intestinali. In particolare, le persone over 40 con sanguinamento rettale dovrebbero sempre sottoporsi a una valutazione medica completa.
Q4. Quali sono i trattamenti disponibili per le emorroidi? I trattamenti variano dalla semplice gestione dei sintomi con rimedi casalinghi e farmaci topici, a procedure ambulatoriali mini-invasivi, fino agli interventi chirurgici nei casi più gravi. La scelta del trattamento dipende dalla gravità della condizione e dalla risposta alle terapie conservative.